 Ieri sera ho finito di leggere “Settantadue – #DialisiCriminale” di Simone Pieranni, edito dalla neonata collana di Alegre: Quinto Tipo. Un libro particolare, diverso dal solito, in cui il tema trattato non è la solita insoddisfazione borghese riguardo la propria vita che tanto piace alle case editrici contemporanee. No. E’ un libro che racconta che vuol dire stare 12 ore a settimana attaccati ad una macchina per dialisi e molto altro.
Ieri sera ho finito di leggere “Settantadue – #DialisiCriminale” di Simone Pieranni, edito dalla neonata collana di Alegre: Quinto Tipo. Un libro particolare, diverso dal solito, in cui il tema trattato non è la solita insoddisfazione borghese riguardo la propria vita che tanto piace alle case editrici contemporanee. No. E’ un libro che racconta che vuol dire stare 12 ore a settimana attaccati ad una macchina per dialisi e molto altro.
«La verità: il novantanove per cento delle persone non ha idea di cosa sia la dialisi. Allora a quel punto o spieghi o stai zitto. Io sto zitto»
Prima di spiegare cosa e perché mi sia piaciuto è giusto premettere che sono un (pessimo) amico di Simone Pieranni, che nella vita scrive per Il Manifesto dopo aver fondato l’agenzia giornalistica China Files in quel di Pechino. E non lo dico perché “aò anacapito so amico dello scrittore” ma perché è naturale che il mio giudizio tanto quanto le mie percezioni siano in qualche modo filtrate da un affetto e una stima che esiste.
Su Il Manifesto di domenica scorsa c’era una bella recensione di questo libro e del rapporto tra letteratura e malattia. Sul fatto che spesso e volentieri chi si è ritrovato a raccontare la propria malattia lo abbia fatto mettendo al centro la propria sofferenza, il proprio dolore. Simone non lo fa. A Simone “rode proprio il culo” come si dice nella “sua” nuova città. E’ rabbioso, incazzato, non vuol cedere un centimetro a una malattia che vorrebbe fargli rinunciare a parti importanti della propria vita. Ни шагу назад! (Nessun passo indietro!) ordinò Stalin nel 1942 e Pieranni non vuol farli. Non ne fa neanche uno raccontando questi ultimi 3 anni pari a 1728 ore, dieci settimane, da quando la sua vita indubbiamente cambiò.
Settantadue non ha una storia lineare. Mischia fiction, autobiografia, parti di inchiesta. A volte disorienta, anzi volutamente disorienta. La Macchina, Genova, Shangai, Roma, sono i piani in cui divide questo frammentato racconto. La rabbia tiene tutto insieme. La tenacia e la resistenza fanno il resto. E riesce anche a divertire, con quell’umorismo nero e cattivo (che a dire il vero ha sempre avuto), di chi tifa la “morte di quel vecchio che urla accanto” o dei racconti di criminalità del compagno di dialisi, ex affiliato alla Banda della Magliana. Perché nell’estrema sensibilità di Pieranni ce n’è una che più di ogni altra mi ha colpito: da Roma alla Cina, descrivendo ospedali, inservienti, dottori e malati, Simone riesce a cogliere quelle sfumature umane dei suoi compagni di viaggio. Sente i luoghi, riconosce le persone, ne intuisce le sfumature. Altrimenti non avrebbe potuto descrivere così bene, che sia fiction o no, quella Roma che neanche in infanzia l’autore ha vissuto, tra i baretti di Ostia e quelli di una Monteverde sparita, dove criminali e fascisti passavano il tempo tra una rapina e gli scontri con i compagni.
Ma non posso nascondere il turbamento che ho avuto in alcune pagine, soprattutto quelle più introspettive, quelle rabbiose, dove Simone sanguina, metaforicamente e non. Non siamo al punk dei “costretti a sanguinare” siamo nell’intimo di un uomo, di un amico, che ha scelto di raccontarsi. E a me questa intimità, fa scattare un senso di pudore enorme, come se stessi violando i segreti di una persona. Soprattutto se è una persona a cui ti senti legato. Limite mio, ci mancherebbe. Conoscere le paure delle persone, le loro angosce, la loro nudità mi crea questo. E quella rabbia che sentivo di condividere, di riconoscere, di sentire in parte mia, svanisce. Perché ci sono sensazioni, situazioni, dolori che non si conoscono e che anzi siamo fortunati di non vivere. Tutto ridiventa più piccolo, meno importante. Rimane solo una rabbia contagiosa che non fatichiamo a fare anche nostra.
«Dire, fare, baciare. Salvare la vita». E daje Simò.
 Si rimane sempre sorpresi quando si legge un nuovo fumetto di Paco Roca. E’ uno stupore particolare quello di chi nonostante le alte aspettative riesce sempre a trovare qualcosa di inaspettato e a stupirsi per la bravura dell’autore. Con “La Casa” uscito appena una settimana fa, Paco Roca conferma di essere uno dei migliori in circolazione oltre a confermare il fatto che in questi ultimi mesi stanno uscendo dei fumetti molto belli, di un livello così alto che si rischia di abituarcisi troppo. Continued…
Si rimane sempre sorpresi quando si legge un nuovo fumetto di Paco Roca. E’ uno stupore particolare quello di chi nonostante le alte aspettative riesce sempre a trovare qualcosa di inaspettato e a stupirsi per la bravura dell’autore. Con “La Casa” uscito appena una settimana fa, Paco Roca conferma di essere uno dei migliori in circolazione oltre a confermare il fatto che in questi ultimi mesi stanno uscendo dei fumetti molto belli, di un livello così alto che si rischia di abituarcisi troppo. Continued… Difficile non ricordare i 6 giorni successivi l’assoluzione dei poliziotti rei di aver pestato quasi a morte Rodney King, colpevole di essere nero agli occhi di uno dei corpi di polizia più violenti e militarizzati non solo d’America. Difficile dimenticare come una rivolta popolare dei neri afroamericani e degli ispanici abbia messo sotto scacco una delle prime potenze mondiali e militari per ben 6 giorni tanto da schierare nelle strade Marines, Guardia Nazionale e un po’ tutti i corpi di polizia in circolazione per riportare “la pace” nelle strade di Los Angeles. E’ una pagina di storia indelebile ed è proprio su quelle giornate che si muove il quarto romanzo (primo edito in Italia) di
Difficile non ricordare i 6 giorni successivi l’assoluzione dei poliziotti rei di aver pestato quasi a morte Rodney King, colpevole di essere nero agli occhi di uno dei corpi di polizia più violenti e militarizzati non solo d’America. Difficile dimenticare come una rivolta popolare dei neri afroamericani e degli ispanici abbia messo sotto scacco una delle prime potenze mondiali e militari per ben 6 giorni tanto da schierare nelle strade Marines, Guardia Nazionale e un po’ tutti i corpi di polizia in circolazione per riportare “la pace” nelle strade di Los Angeles. E’ una pagina di storia indelebile ed è proprio su quelle giornate che si muove il quarto romanzo (primo edito in Italia) di  Questa non è la recensione dell’ultimo fumetto di
Questa non è la recensione dell’ultimo fumetto di  Ieri sera ho finito di leggere
Ieri sera ho finito di leggere  Potrei risolvere la recensione di “
Potrei risolvere la recensione di “
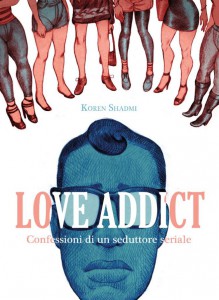
 Per chi, come me, è cresciuto a pane e Mister No trovarsi tra le mani un fumetto, una storia, ambientata in quella Manaus del dopoguerra è un po’ come ritrovare i luoghi dell’infanzia. Oltretutto
Per chi, come me, è cresciuto a pane e Mister No trovarsi tra le mani un fumetto, una storia, ambientata in quella Manaus del dopoguerra è un po’ come ritrovare i luoghi dell’infanzia. Oltretutto  Quando un paio d’anni fa lessi
Quando un paio d’anni fa lessi  Riapro. A quasi 15 mesi di distanza ma questa volta senza attaccare mine sul fatto che stavolta sarò serio, stavolta scriverò puntuale. Stavolta sarà diverso che poi è il fallimentare mantra della vita mia a cui manco credo.
Riapro. A quasi 15 mesi di distanza ma questa volta senza attaccare mine sul fatto che stavolta sarò serio, stavolta scriverò puntuale. Stavolta sarà diverso che poi è il fallimentare mantra della vita mia a cui manco credo.